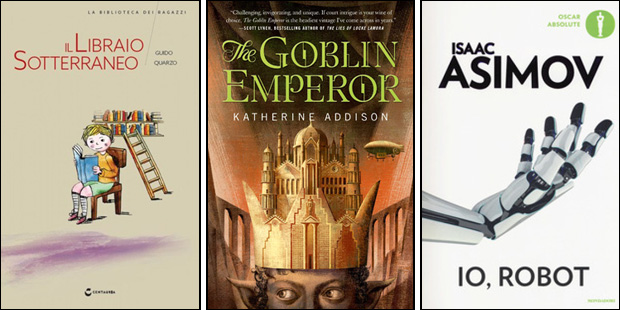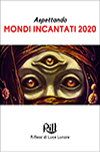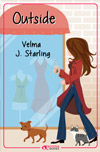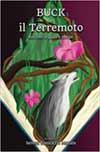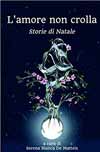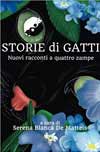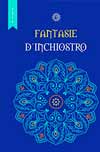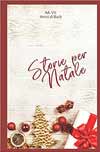Letture di Gennaio 2022
L’unica cosa buona di essere nel pieno di una convalescenza, dopo un problema non troppo grande ma nemmeno troppo piccolo alle ossa di una spalla, è poter stare tanto tempo in poltrona a leggere con calma e tranquillità. Così ho pensato di giocarmi buona parte del mese su dei pezzi da novanta…
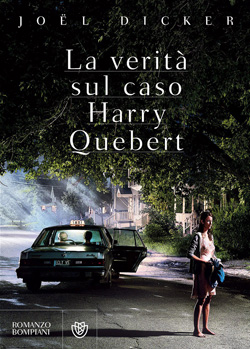 La primissima lettura dell’anno era lì che mi aspettava da qualche annetto: La verità sul caso Harry Quebert, di Joël Dicker (in Italia per Bompiani). C’è da ringraziare che qui lo abbia scritto giusto, perché più spesso mi confondo e lo chiamo “Il caso Harry Quebert”, che invece è il titolo del libro… del quale si parla dentro al libro. Insomma sì, è un libro che parla anche di libri e di scrittori, ma soprattutto di un delitto che è stato consumato molti anni prima rispetto al presente della narrazione (insomma un cold case) e su cui il protagonista deve indagare per togliere dai guai un caro amico. L’ho letto velocemente: in effetti è uno di quei romanzi studiati apposta per farti girare una pagina dopo l’altra, pieno di rivelazioni inserite ad arte nei momenti giusti, di scampoli di filosofia spicciola in cui chiunque può riconoscersi (a dire il vero con un po’ troppo effetto Baci Perugina), di personaggi interessanti e sfaccettati misti ad altri tagliati con l’accetta (spiccano in quest’ultima categoria l’editore e la madre del protagonista, due macchiette insostenibili). La storia lascia emozioni profonde o concetti pregnanti? No, ma è un buon libro di intrattenimento, requisito principale di ogni poliziesco che si rispetti.
La primissima lettura dell’anno era lì che mi aspettava da qualche annetto: La verità sul caso Harry Quebert, di Joël Dicker (in Italia per Bompiani). C’è da ringraziare che qui lo abbia scritto giusto, perché più spesso mi confondo e lo chiamo “Il caso Harry Quebert”, che invece è il titolo del libro… del quale si parla dentro al libro. Insomma sì, è un libro che parla anche di libri e di scrittori, ma soprattutto di un delitto che è stato consumato molti anni prima rispetto al presente della narrazione (insomma un cold case) e su cui il protagonista deve indagare per togliere dai guai un caro amico. L’ho letto velocemente: in effetti è uno di quei romanzi studiati apposta per farti girare una pagina dopo l’altra, pieno di rivelazioni inserite ad arte nei momenti giusti, di scampoli di filosofia spicciola in cui chiunque può riconoscersi (a dire il vero con un po’ troppo effetto Baci Perugina), di personaggi interessanti e sfaccettati misti ad altri tagliati con l’accetta (spiccano in quest’ultima categoria l’editore e la madre del protagonista, due macchiette insostenibili). La storia lascia emozioni profonde o concetti pregnanti? No, ma è un buon libro di intrattenimento, requisito principale di ogni poliziesco che si rispetti.
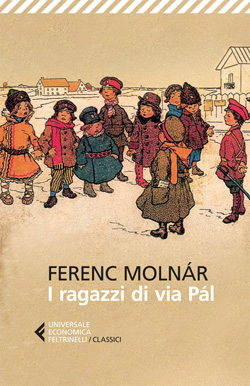 Qualche tempo fa mi sono imbattuta per caso in un vecchio post di questo blog che pubblica tavole a fumetti tratte da storiche riviste come il Corriere dei piccoli, il Corriere dei ragazzi e Il giornalino. Il vecchio post in questione riporta un testo a firma Egisto Corradi, pubblicato sul Corriere dei Piccoli n. 52 del 24 dicembre 1961, in cui l’autore riporta un suo viaggio a Budapest, nel quartiere in cui si svolgono le avventure narrate nel romanzo I ragazzi della via Pal. Anzi, Corradi era stato proprio in via Pal essa stessa medesima, e aveva addirittura conosciuto una delle persone a cui Ferenc Molnàr si era ispirato per creare i suoi personaggi: quelle due bande di ragazzi che, tra riunioni segrete e lezioni a scuola, si contendevano l’una con l’altra il campo incolto in cui ritrovarsi e passare il tempo in compagnia. Insomma ho ripreso la mia vecchissima copia del romanzo e ne ho rilette alcune parti, e accidenti quanto è bello. È proprio un ritratto sincero delle turbolenze che vivono negli animi dei ragazzi, su argomenti che agli adulti sembrano scemenze di infimo livello e invece per loro sono vitali; il tutto mescolato a zuffe, litigi, riappacificazioni, un’epica battaglia e un finale amarissimo. Averne, di romanzi per ragazzi che hanno così tanto da insegnare anche a coloro che ragazzi non sono più.
Qualche tempo fa mi sono imbattuta per caso in un vecchio post di questo blog che pubblica tavole a fumetti tratte da storiche riviste come il Corriere dei piccoli, il Corriere dei ragazzi e Il giornalino. Il vecchio post in questione riporta un testo a firma Egisto Corradi, pubblicato sul Corriere dei Piccoli n. 52 del 24 dicembre 1961, in cui l’autore riporta un suo viaggio a Budapest, nel quartiere in cui si svolgono le avventure narrate nel romanzo I ragazzi della via Pal. Anzi, Corradi era stato proprio in via Pal essa stessa medesima, e aveva addirittura conosciuto una delle persone a cui Ferenc Molnàr si era ispirato per creare i suoi personaggi: quelle due bande di ragazzi che, tra riunioni segrete e lezioni a scuola, si contendevano l’una con l’altra il campo incolto in cui ritrovarsi e passare il tempo in compagnia. Insomma ho ripreso la mia vecchissima copia del romanzo e ne ho rilette alcune parti, e accidenti quanto è bello. È proprio un ritratto sincero delle turbolenze che vivono negli animi dei ragazzi, su argomenti che agli adulti sembrano scemenze di infimo livello e invece per loro sono vitali; il tutto mescolato a zuffe, litigi, riappacificazioni, un’epica battaglia e un finale amarissimo. Averne, di romanzi per ragazzi che hanno così tanto da insegnare anche a coloro che ragazzi non sono più.
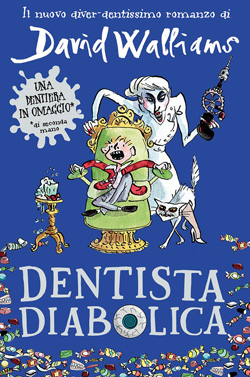 A proposito di romanzi per un pubblico giovane: Dentista diabolica, di David Williams (ed. L’Ippocampo), è stato un tentativo di ripescare un libro acquistato qualche anno fa e mai degnato di uno sguardo da Mini-Velma. Siccome di recente si è riavvicinata alla lettura, ho provato a vedere se fosse possibile proporglielo, e la risposta è stata un sonoro NO. A parte un problemino di età, per cui un libro che poteva andare bene quando lei aveva dieci anni è troppo passato di cottura adesso che ne ha quasi tredici, c’è anche da dire che probabilmente non le sarebbe piaciuto nemmeno tre anni fa. Per quanto questo autore sia osannato, tanto che alcuni addirittura lo paragonano a Roald Dahl, e per quanto la libraia mi avesse detto che era molto divertente, io in tutta onestà l’ho trovato banale. O meglio, volutamente banale, come se i bambini di 8-10 anni dovessero essere un po’ scemi di default. L’uso di personaggi di una piattezza esagerata, l’inserimento di scene-riempitivo fatte per strappare una risata ma alla lunga stucchevoli, e poi il dover segnalare ogni volta quando una parola è inventata perché non sia mai che i bambini non se ne accorgano da soli… non so. Secondo me i bambini e i preadolescenti meritano di essere presi più sul serio.
A proposito di romanzi per un pubblico giovane: Dentista diabolica, di David Williams (ed. L’Ippocampo), è stato un tentativo di ripescare un libro acquistato qualche anno fa e mai degnato di uno sguardo da Mini-Velma. Siccome di recente si è riavvicinata alla lettura, ho provato a vedere se fosse possibile proporglielo, e la risposta è stata un sonoro NO. A parte un problemino di età, per cui un libro che poteva andare bene quando lei aveva dieci anni è troppo passato di cottura adesso che ne ha quasi tredici, c’è anche da dire che probabilmente non le sarebbe piaciuto nemmeno tre anni fa. Per quanto questo autore sia osannato, tanto che alcuni addirittura lo paragonano a Roald Dahl, e per quanto la libraia mi avesse detto che era molto divertente, io in tutta onestà l’ho trovato banale. O meglio, volutamente banale, come se i bambini di 8-10 anni dovessero essere un po’ scemi di default. L’uso di personaggi di una piattezza esagerata, l’inserimento di scene-riempitivo fatte per strappare una risata ma alla lunga stucchevoli, e poi il dover segnalare ogni volta quando una parola è inventata perché non sia mai che i bambini non se ne accorgano da soli… non so. Secondo me i bambini e i preadolescenti meritano di essere presi più sul serio.
Meno male che poi mi sono rifatta con Il libraio sotterraneo di Guido Quarzo (ed. Salani), che si è guadagnato un post a parte nella categoria “Librini”: ho trovato più sostanza in questo centinaio di paginette scritte larghe, che nelle oltre 400 (larghette pure loro, eh) della Dentista diabolica. Un altro libro di cui ho parlato in un post per conto suo è The Goblin Emperor, un gran bel fantasy scritto da Katherine Addison, purtroppo mai tradotto in Italia. In futuro invece scriverò un post su quella meraviglia di raccolta di racconti che è Io, robot, di Isaac Asimov (in edizione Mondadori): pietra miliare della fantascienza, tuttora godibile, scorrevole, quasi come se il tempo non fosse passato.
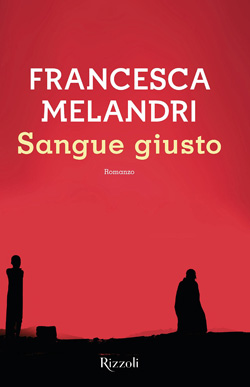 Infine, ho concluso le letture di questo mese con due titoli da far tremare i polsi. Il primo è Sangue giusto, di Francesca Melandri (io ho l’edizione Rizzoli BUR, ma di recente è stato ripubblicato da Bompiani), che mi aveva già chiamata più volte dallo scaffale della libreria ed era stufo di rimanere inascoltato. Di questa autrice ho già letto e amato Eva dorme e Più alto del mare (v. la parte finale di questo post), e anche stavolta non sono rimasta delusa. Ho soltanto fatto fatica a ingranare, perché la parte iniziale del romanzo la “butta in politica” in modo troppo indignato & disgustato, anche quando si parla di uno come Berlusconi. Poi nel giro di un centinaio di pagine la vicenda prende il via trovando un equilibrio migliore fra la narrazione e le critiche alla politica italiana nei riguardi dei paesi africani, oggi come in epoca fascista. Il personaggio di Attilio Profeti mi è piaciuto moltissimo, nel suo qualunquismo misto a furbizia e meschinità (mi ha ricordato Hugo Lamb dalle meravigliose pagine di Le Ore Invisibili), ma anche a paure ancestrali e a un amore che, volente o nolente, lo aveva travolto (illuminante la pagina in cui lui spiega ad Abeba le teorie razziali e scopre che lei in linea di principio le condivide, perché è razzista a sua volta nei confronti di stirpi etiopi diverse dalla propria). Attraverso la vita di questo personaggio ci addentriamo nell’occupazione italiana dell’Etiopia, nella politica coloniale e nelle sue conseguenze odierne, scoprendone tanti aspetti eppure mai abbastanza: uno stato di “conoscenza incompleta” a cui anche la protagonista dovrà rassegnarsi nelle ultimissime pagine, sebbene in modo diverso da quello che accade al lettore. Un libro che non lascia indifferenti, come minimo.
Infine, ho concluso le letture di questo mese con due titoli da far tremare i polsi. Il primo è Sangue giusto, di Francesca Melandri (io ho l’edizione Rizzoli BUR, ma di recente è stato ripubblicato da Bompiani), che mi aveva già chiamata più volte dallo scaffale della libreria ed era stufo di rimanere inascoltato. Di questa autrice ho già letto e amato Eva dorme e Più alto del mare (v. la parte finale di questo post), e anche stavolta non sono rimasta delusa. Ho soltanto fatto fatica a ingranare, perché la parte iniziale del romanzo la “butta in politica” in modo troppo indignato & disgustato, anche quando si parla di uno come Berlusconi. Poi nel giro di un centinaio di pagine la vicenda prende il via trovando un equilibrio migliore fra la narrazione e le critiche alla politica italiana nei riguardi dei paesi africani, oggi come in epoca fascista. Il personaggio di Attilio Profeti mi è piaciuto moltissimo, nel suo qualunquismo misto a furbizia e meschinità (mi ha ricordato Hugo Lamb dalle meravigliose pagine di Le Ore Invisibili), ma anche a paure ancestrali e a un amore che, volente o nolente, lo aveva travolto (illuminante la pagina in cui lui spiega ad Abeba le teorie razziali e scopre che lei in linea di principio le condivide, perché è razzista a sua volta nei confronti di stirpi etiopi diverse dalla propria). Attraverso la vita di questo personaggio ci addentriamo nell’occupazione italiana dell’Etiopia, nella politica coloniale e nelle sue conseguenze odierne, scoprendone tanti aspetti eppure mai abbastanza: uno stato di “conoscenza incompleta” a cui anche la protagonista dovrà rassegnarsi nelle ultimissime pagine, sebbene in modo diverso da quello che accade al lettore. Un libro che non lascia indifferenti, come minimo.
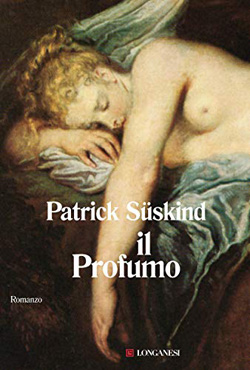 La stessa cosa potrei dirla per l’ultima lettura del mese: Il profumo, del tedesco Patrick Süskind (ed. Longanesi). Ne avevo sentito parlare per anni ma non lo avevo mai preso in considerazione, finché il caso ha voluto che comparisse nella lista dei libri in vendita di una persona da cui stavo per acquistare già un altro paio di libri usati; e allora ho aggiunto anche quello, dicendomi “dài che è ora”. E accidenti se era ora! All’inizio l’ho trovato difficile da “agganciare”, soprattutto perché è pochissimo dialogato, mentre di solito a me piace trovare tanti dialoghi… ma una volta fatta l’abitudine, ho iniziato a godermi la sua prosa elaborata (che descrive oggettivamente i fatti, anche i più beceri, senza emettere giudizi né introdurre messaggi) e il suo protagonista, diverso da qualunque altro personaggio io abbia già conosciuto. Ogni fase della vita di Grenouille lascia il segno, ogni sua evoluzione affascina e inquieta. Il finale è assurdamente coerente con tutto il resto: ti fa rabbrividire eppure, in un certo senso, ti riappacifica con gli eventi precedenti, in una sorta di giustizia poetica che solo Grenouille stesso poteva scegliere.
La stessa cosa potrei dirla per l’ultima lettura del mese: Il profumo, del tedesco Patrick Süskind (ed. Longanesi). Ne avevo sentito parlare per anni ma non lo avevo mai preso in considerazione, finché il caso ha voluto che comparisse nella lista dei libri in vendita di una persona da cui stavo per acquistare già un altro paio di libri usati; e allora ho aggiunto anche quello, dicendomi “dài che è ora”. E accidenti se era ora! All’inizio l’ho trovato difficile da “agganciare”, soprattutto perché è pochissimo dialogato, mentre di solito a me piace trovare tanti dialoghi… ma una volta fatta l’abitudine, ho iniziato a godermi la sua prosa elaborata (che descrive oggettivamente i fatti, anche i più beceri, senza emettere giudizi né introdurre messaggi) e il suo protagonista, diverso da qualunque altro personaggio io abbia già conosciuto. Ogni fase della vita di Grenouille lascia il segno, ogni sua evoluzione affascina e inquieta. Il finale è assurdamente coerente con tutto il resto: ti fa rabbrividire eppure, in un certo senso, ti riappacifica con gli eventi precedenti, in una sorta di giustizia poetica che solo Grenouille stesso poteva scegliere.